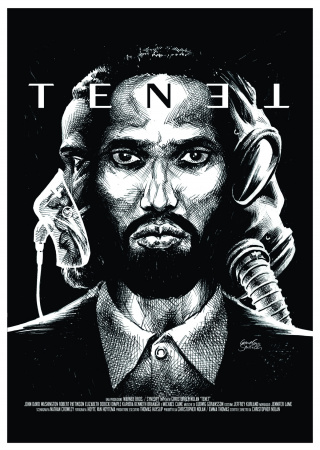L'immagine della settimana

Editoriale 06/2026
I tempi felici verranno Preston
Il primo consiglio è quello di non perdersi Send Help di Sam Raimi, film che, nonostante abbia uno sviluppo narrativo un poco prevedibile, è la risposta esasperata, anti-intellettualista e per solo due personaggi di Triangle of Sadness di Ruben Östlund, un mix sovreccitato di guerra dei sessi e lotta di classe, una chiosa ghignante e insieme funerea al Sogno americano e alla società dello spettacolo odierna: il “figlio di” messo a tacere dal “caso umano” notiziabile, dal protagonista del fatto di cronaca elevato dall’opinione pubblica a nuovo eroe, a dire benissimo di come si muove l’ascensore sociale (e la logica dei media) di un mondo troppo idiota. Un mondo che la protagonista (Rachel McAdams) impara ad abitare: ed è questo il suo coming of age scorretto e terrificante, proprio come per la “fantastica Amy” di L’amore bugiardo, oggi un classico. E, come il film di David Fincher, Send Help è una possibile versione cinica, incupita, caricaturale, surreale del cinema di un maestro della commedia statunitense, Preston Sturges (i primi cinque suoi film che mi vengono in mente? Lady Eva, Ritrovarsi, Evviva il nostro eroe, Infedelmente tua e naturalmente I dimenticati, alla base di Fratello, dove sei? dei Coen). Un regista che, dietro la meccanica perfetta delle sue commedie sofisticate, sapeva che i dialoghi adatti al proprio tempo non erano utili a comunicare, ma erano la forma giusta e terribile per riempire il vuoto, per impedire il pensiero, e che gesti, parole, suoni e immagini correvano a rotta di collo proprio perché il mondo contemporaneo andava troppo veloce per essere compreso dall’umanità. Sturges è stato uno degli autori maggiormente politici del cinema hollywoodiano, proprio perché non sembrava mai esserlo. E la sua America era una abnorme commedia degli errori, governata non tanto dagli ideali dei singoli, ma da implacabili e ottusi automatismi sociali. Nei film tragici e comici di Fincher (tendente alla screwball) e Raimi (tendente allo slapstick), gli errori diventano orrori, gli automatismi sociali sono anche soprattutto mediali, ma il punto non cambia, è solo l’America a essere peggiore. E allora, compiuto il dovere di promuovere un film in sala, passo al secondo consiglio, segnalando un film che al cinema avrebbe dovuto esserci, prima del flop al botteghino Usa e delle stroncature sceme della critica, e che quindi è finito direttamente in streaming su Disney+: Ella McCay di James L. Brooks. Un’opera in cui non c’è solo lo spettro di Sturges ad aleggiare, nei dialoghi, nel ritmo, nei paradossi, ma anche il cinema di Frank Capra e Gregory LaCava, su su fino alla commedia degli anni 80 e 90 di cui Brooks è stato protagonista: un film ambientato nel 2008, al tempo della crisi dei mutui subprime (come Drag Me to Hell di Raimi), in un’epoca decisamente pre-trumpiana in cui «eravamo tutti meno cattivi», certo, ma con una protagonista (Emma Mackey) che è comunque una James Stewart idealista e inadeguata dentro un automatismo sociale e mediatico (quello della politica) che impara non a vincere, ma quantomeno a sfruttare, in uno sparuto angolino, per il bene. Qui non si ride solo di superba farsa grottesca, come in Raimi: da governatrice Ella si impegna per la cura dentale, per il sorriso, dei meno abbienti. E per il nostro: «Il contrario di trauma forse non è speranza» si dice nel film, «ma di certo ci si avvicina». Un magnifico palliativo leggiadro e impotente ai traumi del presente, nostalgico perché già al passato, non credibile per precisa idea politica, coraggiosamente fuori tempo e scritto sapendo d’essere incompreso. Ma non c’è nulla come il cinema classico americano. Nulla come chi, oggi, lo sa ricordare. E nulla come ammirare i fantasmi di Sturges, Capra o LaCava, una vera e propria visione del mondo, insistere e resistere in sparuti angoli del presente. I tempi felici non verranno presto, ma per un paio di film, per un pugno di ore, poco importa.